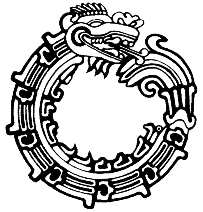Opel Corsa Enjoy TD, 130 km all'ora di media, strada statale 36. Solo qualche Suv Mercedes che mi supera dopo avermi minacciato con il lampeggiio degli abbaglianti; sul tetto gli sci ancora incrostati di neve che trafiggono l'aria gelida, come una polena.
Il tratto di superstrada è quello tra Colico e Lecco, disseminato da gallerie e improvvisi squarci pittorici di lago, lo stesso che fa alzare il culo miliardario di George Clooney e prenotare un biglietto aereo per l'Italia. Ora è però calato un velo scuro e avvolgente di foschia. Somiglia alla nebbia padana che incontrerò tra pochi chilometri, ma qui sono semplicemente nuvole basse che si afflosciano come palloncini obesi. Tra una quarantina di minuti, prima di mezzanotte, dovrei essere arrivato a Cinisello Balsamo dove immettermi sulla bretella Milano-Meda, con cui raggiungere finalmente la mia abitazione in Bovisa.
Dal contenitore in cui si ammassano i cd, pesco a caso una raccolta di musica classica offerta in allegato con la Repubblica, e dopo averla imboccata all'autoradio partono le prime note del Preludio e Fuga n° 1 BWV 846 dal “Clavicembalo ben temperato” di Johan Sebastian Bach, con Svjatoslav Richter al piano. Bach è Bach, ok. E anche Richter. Se poi ci aggiungi la foschia, le nuvole basse, l'andirivieni ipnotico dei faretti gialli delle gallerie, in un tempo e in un luogo che non sono ancora nessun luogo e nessun tempo... Beh, io a questa sensazione riesco a dare un solo nome: bellezza.
All'inizio della passeggiata delle dita lunghe affusolate del pianista ucraino sulla tastiera, ecco però come un'incrinatura, la polena che cigola all'urto di un'onda più forte delle altre. Ma si tratta solamente, me ne accorgo in seguito, dell'accidentale colpo di tosse di una persona presente tra il pubblico. Il primo colpo di tosse, meglio. A cui dopo pochi secondi ne segue un altro e un altro ancora. Un produttore e un editore seri, anche se tu sei Bach, tu sei Richter, è chiaro che buttano via l'incisione, quando qualcuno tra i presenti inizi e continui ostinatamente a tossicchiare, per tutta la durata dell'esecuzione. Non la Repubblica, evidentemente.
Ma chi se ne importa, non è questo il punto, e io provo a mettermi in scia all'ennesima Mercedes continuando ad ascoltare, se è possibile con maggiore urgenza e piacere di prima. Come se ogni intrusione della laringe infiammata sottolineasse, per contrasto, la potenza espressiva e incantatrice della melodia, che in tal modo viene accresciuta della qualità preziosa e rara della consapevolezza.
Un piccolo e ripetuto incidente che mi suggerisce come la bellezza, per raggiungere la piacevole e universalmente sperimentata sensazione di benevola naturalità, sia spesso, e al contrario, un gesto sottilmente "anti-naturale". Ossia l'impegno umano nel sottrarsi al baricentro gravitazionale del caso, dell'incuria, degli infiniti accidenti quotidiani che senza sforzo o intenzione o coscienza sbocciano nel parco della vita alla rinfusa, con la grazia sghemba di un colpo di tosse durante un'esecuzione di Bach.
Questo tratto di resistenza al caso e, potremmo dire con un'espressione vagamente altisonante, all'entropia, che caratterizza la bellezza urticata dai continui assalti della tosse, mi sembra poi una struggente metafora di quel che siamo diventati, della direzione in cui stiamo andando con il piede spensieratamente pigiato sull'acceleratore.
Ma un secondo, scusate l'interruzione: "Massì massì, ho capito: piantala di farmi gli abbaglianti e passa pure tu! Con la tua Mercedes scalpitante e innevata, la fretta matta dei funghi che vogliono raggiungere la statura della quercia in una sola notte, mentre la punta degli sci mira al cuore pulsante di un qualche demone moderno, che dilaga per le strade."
Perché cos'è diventata l'Italia, il nostro paese, la stessa idea di patria, se non una sublime melodia continuamente infestata dagli assalti rauchi della tosse, che provengono da quello sterminato e disattento pubblico che sono ormai gli italiani in gita?