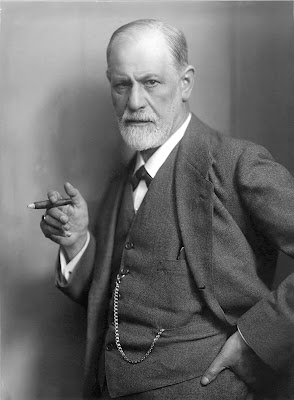Che cos’è un
cretino? E come funziona, quali i suoi meccanismi interni, le sue rotelle?
Immagino che la cosa migliore sia domandarlo direttamente a un cretino. Io, ad
esempio.
In seconda media,
per unanime e solido consenso, si stabilì che io fossi un cretino. La prima ad
averne avuto sentore fu una certa Mevio; giovane e bionda insegnante di
matematica, forse tinta, nella giornate in cui nevicava indossava degli enormi Moon Boot
pelosi. Quando ci spiegò i numeri negativi, fui l’unico a non
capire. Ma come, obiettavo, non si può numerare qualcosa che non c’è,
addirittura dei segni grafici con cui marcare l’inesistente! Se avessi
masticato un po’ di filosofia avrei aggiunto: il non essere non è, al limite,
con i numeri negativi, possiamo esprimere una sorta di debito; in quanto debito
è anch’esso positivo, viene incluso nel cono di luce dell’Essere. Ma ero solo
un cretino di dodici anni, un cretinetti, e mi limitavo a impuntarmi come un
mulo, o meglio un somaro matematico che non vuole riconoscere i numeri negativi.
Poco tempo dopo venne organizzato lo studio per gruppi di livello, e quel precedente mi portò a essere incluso nel gruppo più
basso; il gruppo dei cretini, appunto. Ne facevano parte due ragazze handicappate, il figlio del meccanico da cui andava mio padre che veniva a scuola con le unghie nere e il pugnale della Decima MAS, un pluriripetente di cui non si udiva mai la voce, se non per chiedere “hai
mica una Marlboro”, e infine io. Perfino il mio amico Mascarini, a cui fino a
quel giorno avevo passato i compiti in classe sottobanco, stava in un gruppo
superiore, e cominciò a guardarmi con un certo distaccato sussiego. Come lui
tutti gli altri compagni, disposti in una gerarchia piramidale che culminava
nel gruppo capeggiato dall’Acquistapace, vertice estetico e intellettuale della
seconda F.
Insomma, ero
proprio un cretino, non solo avevo finito per crederlo; tra convinzione
e identità non vi è alcuna differenza, una continua circolarità rimodula percezione collettiva e coscienza di sé. In genere viene spiegato con l'effetto Rosenthal, altri lo chiamano Pigmalione, ma i più intellettuali e snob possono affidarsi allo schema Z di Lacan, oppure a Emanuel Lévinas, Jean-Paul Sartre; tutti nomi che allora non avevo mai sentito nominare. Ma in fondo lo si poteva intuire già dai fumetti di Zagor, di cui allora mi nutrivo. Zagor, lo Spirito con la scure, diviene un eroe nel momento in cui gli indiani della foresta di Darkwood pensano a lui come eroe, gli è bastato indossare un ridicolo costume per ottenere quell'effetto. E devo dire che non mi trovavo male neppure io col mio nuovo costume da cretino: camminavo con una postura da cretino, guardavo programmi
televisivi cretini, e, naturalmente, a parte Zagor, non leggevo nulla.
Passarono molti
anni, più di dieci, in cui lo Zeitgeist degli
anni ottanta faceva da spensierata colonna sonora, puntello acustico al mio status di cretino. Concluse le medie, fui naturalmente dissuaso dal
frequentare il Liceo – io volevo iscrivermi al Liceo classico solo per rivedere
l’Acquistapace, mica per altro – e venni dirottato verso Ragioneria; una scuola
per cretini, sì, certo, ma con l’astuzia di convertirli in utili idioti,
un’alchimia che trasforma in oro (per le banche) la stupidità (propria).
Il cambio di
prospettiva avvenne all’università. Avevo scelto, con slancio naif e in fin dei conti ancora cretino, la facoltà di Filosofia, forse allettato dal prefisso nominale: filo, a ricordarmi il termine figo. Al
termine di una lezione sulla filosofia del linguaggio, in cui il professore
aveva esposto la teoria che aveva a lungo elaborato con il suo gruppo di
studio, lo accostati in corridoio e gli dissi: “Professore, scusi, ma c'è qualcosa che non mi torna. Intendo. Per questa ragione e per
quest’altra, lo vede, c'è un passaggio, da lì in poi diventa tutto arbitrario…”
Lui mi guardò a
lungo, serissimo, quasi minaccioso, e poi rispose: “Ma sai che mi ha detto le stesse cose
John Searle? Bravo! Facciamo così: la prossima lezione
la tieni tu, e ripeti le obiezioni ai tuoi compagni. La filosofia funziona a questo modo, vince chi possiede gli argomenti più convincenti. E, stavolta, avete vinto tu e Searle,” che al tempo era un filosofo molto di moda. Sì, anche in filosofia ci sono le mode, come per l'orlo dei pantaloni.
Alla fine la tenni per davvero, una lezione di fronte a oltre centocinquanta matricole. Non proprio per tutta l’ora,
non ne avevo il coraggio né gli argomenti, ma per una ventina di minuti fui
sospinto dall’adrenalina, a gonfiare parole, concetti ma soprattutto la coda del pavone. Mi guadagnai così la fama di genietto della facoltà. Lo
capivo da come gli altri studenti avevano iniziato a relazionarsi con me: lo
stesso modo in cui mi relazionavo io, in seconda media, con l’Acquistapace.
Ovviamente, anche
questa mutazione percettiva comportò un corrispettivo nel corpo, che come
quando ero cretino – non pensavo di esserlo, ripeto, lo ero proprio – si trasformò in un rapporto più impettito e statuario con lo spazio, gli oggetti, prima ancora che con le persone.
Avendo provato entrambe le condizioni, devo dire che tra essere intelligenti o cretini non cambia molto: si tratta d'interpretare un copione sociale, aderirvi con la cocciuta immedesimazione di chi si affida al metodo Stanislavskij.
Per concludere,
sono un genio oppure un cretino?
A me sembra
tutte e due le cose. E non perché io sia effettivamente qualcosa, je est un
autre, come tutti un passo in là rispetto a identificazioni sempre provvisorie, e l’Acquistapace più in là di tutti: perfetta e intangibile
e a volte un po’ spietata. Direi piuttosto il riflesso, anch'esso mobile e incerto, di
un agglutinato di pensiero che prima ancora che dentro sta fuori, e a cui possiamo sottometterci come fanno i cani quando si sdraiano al suolo (avete ragione voi,
sono proprio cretino) oppure alzare la zampetta e dire: “Scusatemi, ma non sono d’accordo.”
Se riesci ad
abbattere il maschio o la femmina alfa, che è uno ma rappresenta il branco, si cambia di gruppo, la Mevio ti promuove a un
livello superiore e con i suoi Moon Boot ti dà un calcetto nel culo, a
renderti più prossimo alla cima. La prima volta che ci ho provato non ci sono
riuscito, e sono ruzzolato al fondo della piramide (in realtà, sotto sotto, sono ancora
convinto della mia ragione, e trovo i numeri negativi uno strampalato cortocircuito logico…),
mentre la seconda sì. Si trattava sempre di me, la mia intelligenza un uguale fagottino di neuroni, a essere mutato era lo specchio del mondo. Ché alla fine aveva ragione Totò: “Lei è un
cretino! Si informi.”